ULTIME DAL MINISTERO DELL’ECONOMIA
Chiarimenti sulla rideterminazione del Fondo per le Opere Indifferibili

Fondo di solidarietà comunale – Legge di Bilancio – autonomia finanziaria comunale – vincoli di destinazione – strumenti di perequazione – inammissibilità
Corte Costituzionale, sent. 23.02.2023 n. 71/2023
Controllo collaborativo –Richiesta attività consultiva da parte di Unione di comuni – Finanziamento e sviluppo dei servizi sociali comunali – Assunzioni assistenti sociali – Fondo di solidarietà – Vincoli di bilancio
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, 7 marzo 2023, n. 38
Demanio marittimo – Concessioni – Articolo 12, paragrafi 1 e 2, Direttiva 2006/123/CE – Effetto diretto – Obbligo di procedura di selezione imparziale e trasparente – Divieto di rinnovo automatico autorizzazione – Carattere incondizionato e sufficientemente preciso – Normativa nazionale – Disapplicazione
Corte di Giustizia Europea, 20 aprile 2023, sent. C-348/22
Contratti pubblici – Appalti – Cottimo fiduciario – Natura giuridica – Principi applicabili – Bilanciamento – Principio di proporzionalità – Libertà di forme – Effetto utile
Consiglio di Stato, sez. IV, 20 aprile 2023, n. 4014
Agricoltura e zootecnia – Indicazione geografica e denominazione di origine – Norme della Regione Siciliana – istituzione della denominazione comunale [De.Co.]- non fondatezza – inammissibilità
Corte Costituzionale, sent. 23.02.2023 n. 75/2023
Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Onere motivazionale attenuato – Irrilevanza decorso temporale dall’abuso
Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 14 aprile 2023, n. 203
Comuni, Province e Città metropolitane – Norme della Regione autonoma Sardegna – Durata del mandato del Sindaco – Segretario comunale – Modalità di accesso all’albo dei segretari comunali- illegittimità costituzionale
Corte Costituzionale, sent. 07.03.2023 n. 60/2023
Controllo bilanci – Esame relazioni Organo di revisione dell’Ente – Elementi di risposta parziali e non adeguati – Accertamento condotta omissiva – Pregiudizio all’espletamento dell’attività di controllo
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia,
28 marzo 2023, n. 92
Demanio marittimo – Concessioni demaniali – Proroga legale – Azione di accertamento
Consiglio di Stato, sez. VI, 14 marzo 2023, n. 2644
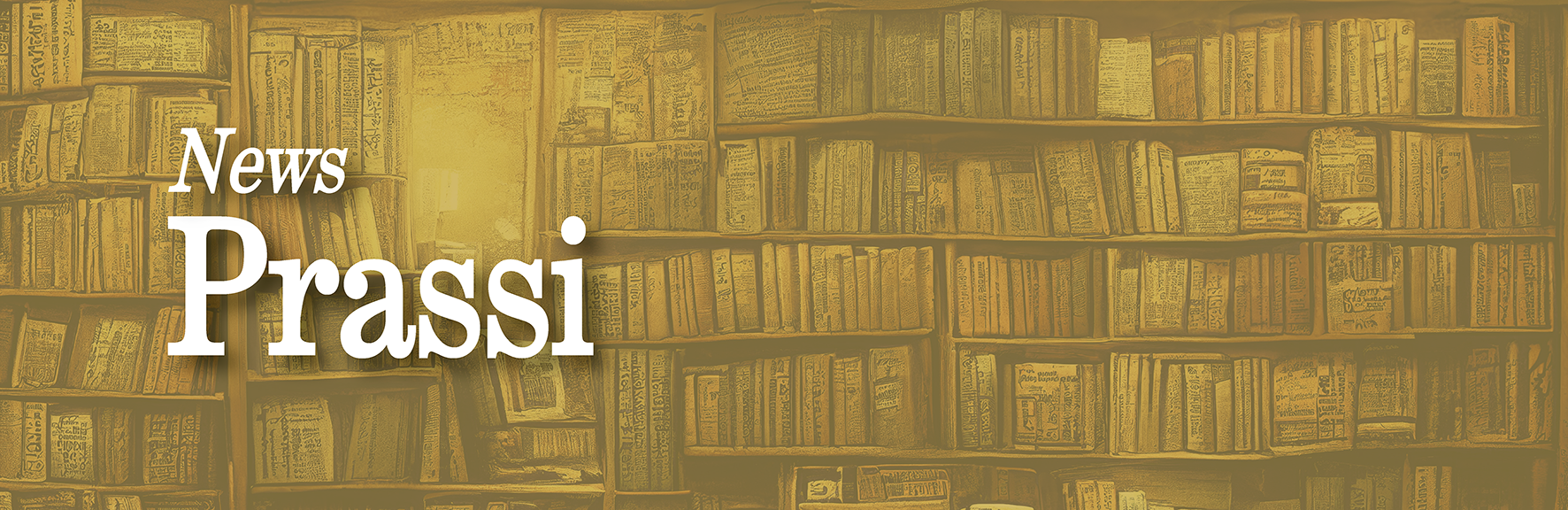
ANCI
Nota
Le norme di semplificazione vigenti per l’attuazione degli interventi di edilizia scolastica anche a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del DL 13/2023, convertito con modificazioni, nella Legge n. 41/2023
ANCI
Nota
Rafforzamento della capacità amministrava dei Comuni
ANAC
Atto del Presidente del 19 aprile 2023
Richiesta di parere in merito alla compatibilità dell’incarico di RPCT con quello di RUP
ANAC
Atto del Presidente del 19 aprile 2023
Comune di Alta Valle Intelvi – raccomandazione ai sensi dell’art. 11 co. 1, lett. b) del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione.
MINISTERO DELL’INTERNO
Circolare DAIT n.66 del 5 maggio 2023
Accesso generalizzato agli indici decennali dei registri dello stato civile.
IFEL
Dossier del 3 aprile 2023
Le Strategie territoriali nella Politica di coesione 2021-2027 – Agenda territoriale nazionale e Ruolo dei Comuni italiani
Conferenza unificata
Seduta del 27 aprile 2023
Incentivi – adesione riorganizzazioni e aggregazioni servizi pubblici locali
AGCOM
Bollettino 16/2023 del 24.04.2023
Avvisi pubblici per l’affidamento esternalizzato dei servizi legali
ARERA
Delibera 18 aprile 2023
Determinazione a consuntivo del corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., per l’anno 2022
Chiarimenti sulla rideterminazione del Fondo per le Opere Indifferibili
Raccolta di pareri in materia di ordinamento delle autonomie locali
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 7 novembre 2025, n. 16
Servizi pubblici – Servizio idrico integrato – Tariffa – Criteri di commisurazione – Tasso di inflazione – Oneri finanziari ulteriori – Esclusione
Il principio normativo del recupero integrale dei costi impone che il metodo tariffario: a) garantisca la correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione; b) escluda, tendenzialmente, il recupero dei costi derivanti da scelte non efficienti, in particolare quelli finanziari; c) tenga conto dei costi ambientali e della risorsa, nonché delle ripercussioni sociali derivanti dal recupero.
L’equilibrio economico e finanziario della gestione, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, implica una valutazione ampia e sostenibile della remunerazione garantita all’operatore e non il riconoscimento tariffario di ogni singolo costo sostenuto. Una volta assicurato il suddetto equilibrio, la regolazione tariffaria non comporta la sterilizzazione di qualsivoglia rischio in capo al gestore, ovvero non garantisce sempre e comunque il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione.
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 3 novembre 2025, n. 853
Titolo edilizio – Permesso di costruire – Istanza – Silenzio assenso – Termini – Consumazione del potere – Normativa Regione siciliana
In base all’art. 2 della l. reg. Sicilia n. 17/1994, decorsi settantacinque giorni dalla presentazione dell’istanza di permesso di costruire completa, senza che l’amministrazione abbia comunicato un provvedimento motivato di diniego, si forma il silenzio-assenso. In tal caso, l’amministrazione consuma il potere di decidere sull’istanza del privato e l’eventuale successivo provvedimento di primo grado di rigetto dell’istanza è da considerarsi tardivo, potendo l’amministrazione successivamente provvedere solamente in via di autotutela.
Consiglio di Stato, sez. V, 22 ottobre 2025, n. 8190
Concessioni amministrative – Concessioni di beni e servizi – Occupazione del suolo pubblico – Rilascio del titolo – Silenzio assenso – Non configurabilità
A fronte della presentazione dell’istanza per il rilascio del titolo concessorio per occupazione di suolo pubblico non rileva la ricorrenza dei presupposti normativi per il relativo rilascio, né l’eventuale illegittimità dell’inerzia serbata dell’amministrazione, che non possono far insorgere il titolo stesso, non assentibile per silentium.
Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 13 ottobre 2025, n. 1621
Consiglio comunale – Consiglieri – Legittimazione ad impugnare – Atti lesivi – Scelta di abbandonare il gruppo – Prerogative – Gruppo misto unipersonale
Va esclusa la legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare in sede giurisdizionale un atto emesso da un organo dello stesso ente al quale essi appartengono (sindaco, giunta comunale e consiglio comunale), ad eccezione dei casi in cui le censure proposte siano rivolte a contestare lesioni della propria sfera giuridica o della propria posizione all’interno dell’organo o dell’ente medesimo, ovvero a contestare la modifica della composizione dell’organo e il relativo funzionamento, ma sempre in relazione ad un interesse connesso alla propria sfera giuridica o alla propria posizione all’interno dell’organo o dell’ente.
La libera scelta del consigliere comunale di abbandonare il gruppo consiliare al quale era originariamente iscritto, costituzionalmente (e statutariamente) garantita, non può, quindi, evidentemente comportare la perdita delle prerogative che sono riconosciute solo ai membri dei gruppi consiliari; sicché si rivela essenziale la possibilità di confluire in un gruppo misto, anche unipersonale, attraverso il quale svolgere appieno le funzioni proprie del munus di consigliere.
Consiglio di Stato, sez. II, 26 settembre 2025, n. 7563
Edilizia e urbanistica – SCIA – Demolizione e ricostruzione – Area vincolata – Diversa sagoma – Mutamento destinazione d’uso – Esclusione – Permesso di costruire – Intervento estraneo – Inefficacia – Poteri repressivi – Termine
È legittimo il provvedimento dichiarativo di inefficacia della SCIA, adottato in data antecedente all’entrata in vigore della legge n. 91 del 15 luglio 2022, relativa ad un intervento di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma di un immobile ricadente in area sottoposta a tutela paesaggistica, trattandosi di nuova costruzione soggetta a permesso di costruire e non di ristrutturazione edilizia.
È legittimo il provvedimento dichiarativo di inefficacia della SCIA relativa ad un intervento edilizio che comporti il mutamento di destinazione d’uso con modifica delle sagome e dei volumi dell’edificio, poiché il passaggio a diversa categoria d’uso funzionale è sempre sottoposto al regime del permesso di costruire.
La presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività per un intervento edilizio sottratto al suo ambito applicativo è improduttiva di effetti, non essendo perciò invocabile il relativo regime giuridico relativo al termine di decadenza dell’intervento repressivo amministrativo.
Nota sintetica sul decreto per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno degli amministratori locali
Delibera n.413/2025 – Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro – 22 Ottobre 2025
Interpello n. 3/2025 – Interpello ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004. Art. 3 comma 3, D.M. 30 gennaio 2015 e applicazione della disciplina del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) – 13 Ottobre 2025
Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. I, 12 settembre 2025, n. 25077
Immobili – Indennità per l’utilizzo senza titolo di immobili – Riduzione del 15% ex art. 3, comma 4, d.l. n. 95/2012 – Decorrenza
La riduzione del 15%, prevista dall’art. 3, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 135 del 2012 (come modificato dall’art. 24, comma 4, lett. a, del d.l. n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 89 del 2014), per le indennità dovute per l’utilizzo a fini istituzionali di immobili, in assenza di titolo, da parte delle Amministrazioni centrali, come individuate dall’Istat ai sensi dell’art. 1, comma 3, della l. n. 196 del 2009, nonché dalle Autorità indipendenti, si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 95 del 2012.
Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, 25 settembre 2025, n. 26080
Giurisdizione – Risarcimento del danno – Lesione affidamento incolpevole – Danno da provvedimento annullato – Comportamento amministrativo – Giurisdizione esclusiva del G.A.
Le controversie che hanno ad oggetto il risarcimento del danno da lesione dell’affidamento incolpevole generato dal rilascio di un provvedimento favorevole poi annullato rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto il relativo comportamento, pur incidendo sul diritto soggettivo all’autodeterminazione negoziale, deve qualificarsi come comportamento amministrativo, riconducibile in via indiretta e mediata, all’esercizio del potere, di cui il privato che chiede il risarcimento lamenta la contrarietà alle regole di buona fede e correttezza che informano anche l’attività autoritativa della p.a.
Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Tributaria, 7 ottobre 2025, n. 26921
ICI – IMU – Terreni agricoli divenuti edificabili – Obbligo dichiarativo – Esclusione – Conoscenza diretta dell’amministrazione – Strumento urbanistico generale
L’onere dichiarativo della variazione degli elementi di imposizione previsto dall’art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (ICI) e, nell’IMU, dall’art. 13, comma 12-ter, D.L. n. 201 del 2011, non sussiste nell’ipotesi in cui la variazione consista nella sopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile in forza dello strumento urbanistico generale adottato dall’ente impositore.
Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. III, 24 ottobre 2025, n. 28278
Enti locali – Responsabilità civile – Danni da opere balneari – Alterazione delle correnti marine – Regione e Comune – Omessa vigilanza – Responsabilità ex art. 2043 c.c. – Inapplicabilità dell’art. 2051 c.c.
La responsabilità della Regione Puglia e del Comune di Porto Cesareo per i danni causati dall’alterazione delle correnti marine a seguito di opere eseguite da concessionari di stabilimenti balneari è configurabile non ai sensi dell’art. 2051 c.c. per beni in custodia, ma ex art. 2043 c.c., per omessa vigilanza sul rispetto delle condizioni imposte dai provvedimenti autorizzatori ai concessionari.