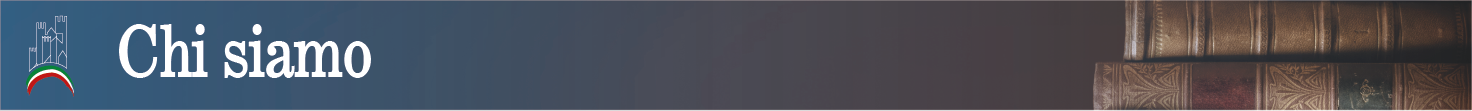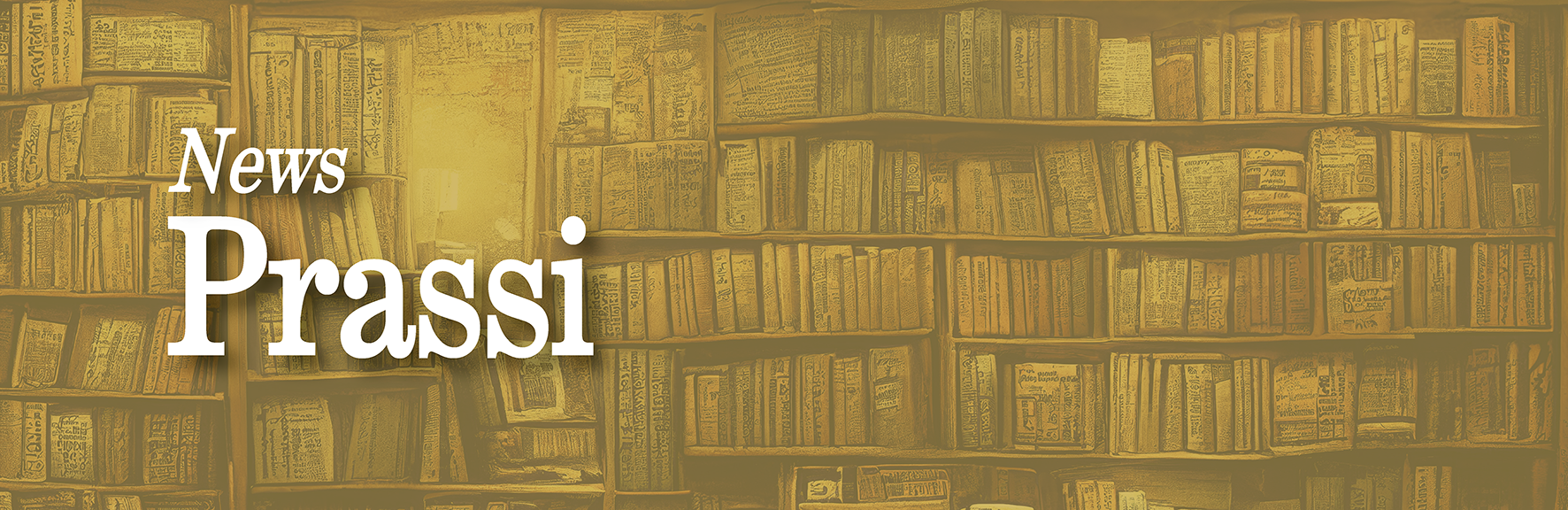Ristrutturazione e cessione di cubatura
Intervento di ristrutturazione – Ricostruzione di un manufatto preesistente su un diverso sedime – Ammissibilità – Cessione di cubatura
L’art. 3 comma 1 lett. d) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come innovato dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, nell’ammettere la ristrutturazione anche in caso di ricostruzione di un manufatto preesistente su un diverso “sedime”, ossia su un’area diversa da quella originariamente occupata dal manufatto da demolire e ricostruire, consente, in assenza di specifiche indicazioni contrarie, siffatta attività edificatoria anche mediante l’utilizzo di un’area diversa, anche se appartenente ad un altro lotto.
La ristrutturazione edilizia secondo la rinnovata ottica desumibile dal tenore testuale dell’art. 3 co. 1 lett. d) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come novellato dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, non è più vincolata da una rigida “continuità” tra le caratteristiche strutturali dell’immobile preesistente e quelle del manufatto da realizzare, ivi inclusa l’area di edificazione, giacché la nozione di sedime richiamata nella nuova formulazione dell’art. 3 lett. d) del t.u. edilizia è, infatti, molto generica e non riporta alcuna specificazione, con conseguente impossibilità di limitarne il concetto all’ambito perimetrale di un determinato lotto.
La ristrutturazione edilizia secondo la rinnovata ottica desumibile dal tenore testuale dell’art. 3 co. 1 lett. d) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come novellato dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, consente di edificare su un diverso lotto avendo riguardo alle capacità edificatorie del terreno da utilizzare, salva la possibilità di ricorrere alla cessione di cubatura.